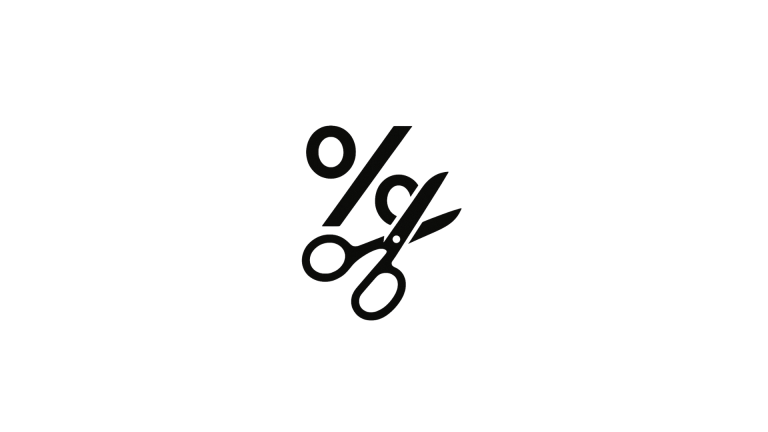1 Ottobre 2025, di Anna Fabi – PMI.it
In Italia, negli ultimi anni, stiamo assistendo con sempre maggiore evidenza al fenomeno del fiscal drag, che agisce quando l’inflazione e gli adeguamenti salariali spingono i contribuenti verso scaglioni più alti in assenza di una piena indicizzazione del sistema: il reddito nominale cresce ma il prelievo aumenta più che proporzionalmente e il reddito effettivo ristagna.
Le evidenze più recenti raccolte da Itinerari Previdenziali e basate sui dati del MEF, segnalano come il fenomeno abbia inciso in modo particolare su lavoratori dipendenti e sul ceto medio nel biennio post-inflazionistico, alimentando quell’effetto trascinamento che rende più onerosi gli scatti contrattuali senza un corrispondente beneficio netto in busta paga.
IRPEF e salari: perché il fiscal drag pesa sul ceto medio
Dal 1° gennaio 2025 la struttura dell’IRPEF a tre aliquote è stata resa stabile: 23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. È proprio il secondo scaglione (28-50 mila euro) a concentrare una quota cruciale di lavoratori “medio-reddito”, quelli più esposti al fiscal drag quando gli scaglioni non vengono aggiornati.
Nel 2024-2025 i redditi dichiarati sono saliti nominalmente, ma il recupero reale ha faticato a tenere il passo con l’inflazione pregressa: se non si adeguano scaglioni e detrazioni, gli aumenti salariali finiscono per essere tassati a margini più elevati.
L’analisi dell’Osservatorio 2025 di Itinerari Previdenziali (basati sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili) ha fatto emergere due elementi: poco più della metà del gettito IRPEF è versato da una minoranza di contribuenti medio-alti; l’erosione del potere d’acquisto ha accresciuto la sensibilità del segmento 28–50 mila al disallineamento tra prezzi e parametri fiscali.
Ipotesi secondo scaglione IRPEF al 33%
Stimando (in modo statico e prudenziale) gli effetti di un taglio di 2 punti dell’aliquota sul segmento 28-50 mila euro, emerge che la riduzione si applicherebbe solo alla porzione di reddito ricadente nello scaglione stesso (massimo 22.000 euro a contribuente).
Poiché i contribuenti tra 29mila e 55 mila sono circa 6,5/7 milioni (e dunque circa 12mila dei redditi totali ricadono tra 28 e 50mila), con una base imponibile in scaglione di circa 81,6 miliardi (6,8 mln × 12.000), applicando una riduzione IRPEF dal 35% al 33%, il beneficio lordo ammonterebbe a circa 1,63 miliardi l’anno ed il vantaggio medio per contribuente sarebbe nell’ordine di circa 240 euro annui (12.000 × 2%).
Con porzioni medie più basse o più alte (8–15 mila), il beneficio totale spazierebbe da 1,1 a 2 miliardi, con un vantaggio pro capite di 160–300 euro.
Attenzione: questa però è una stima statica, non considerando eventuali interazioni con detrazioni fiscali e possibili nuovi tagli del cuneo fiscale inseriti in manovra, né tantomeno l’adeguamento delle addizionali locali. Aiuta però a dare una grandezza del recupero di fiscalità sul ceto medio.ù
In parole semplici, portando l’aliquota marginale al 33% si attenuerebbe l’ingolfamento del secondo scaglione e si restituirebbe ossigeno agli incrementi contrattuali, temperando l’effetto di trascinamento (il fiscal drag spiegato sopra) registrato da dati 2024.
Compatibilità con i conti pubblici e welfare
Nel 2024 i redditi dichiarati hanno generato un gettito IRPEF (al netto di detrazioni e imposte sostitutive) nell’ordine dei 200 miliardi; una riduzione da 1,1 a 2 miliardi rientrerebbe in una forchetta gestibile se accompagnata da coperture e da un disegno coerente su detrazioni e addizionali.
Il vero nodo resta semmai la sostenibilità del welfare: sanità, assistenza e servizi locali assorbono ormai oltre 300 miliardi, cifra che — come evidenzia lo studio di Itinerari Previdenziali — viene finanziata in larga parte dalla fiscalità generale. Perciò qualsiasi taglio dell’IRPEF va valutato nel quadro delle priorità di spesa.